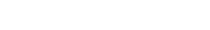Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Installazione condizionatori su parti comuni condominiali
Non sono pochi i casi in cui, complice il caldo estivo, ci si trovi dinanzi a opere aventi a oggetto una incontrollata installazione, su parti condominiali, di motori esterni di impianti di condizionamento privati. Trattasi di questione particolarmente rilevante che infiamma i dibattiti nelle aule di giustizia, che riguarda il diritto del condomino di installare motori dei condizionatori d’aria sulla facciata condominiale.
Sull’argomento si registrano orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci. Dunque, ai fini della soluzione del quesito, occorre valutare la legittimità dell’iniziativa presa dai singoli condomini e, quindi, analizzare la questione dal punto di vista normativo e giurisprudenziale.
LA FACCIATA DEL CONDOMINIO - Secondo il Codice civile (art. 1117 del Codice civile), la facciata rientra tra le parti comuni del condominio. Invero, la facciata dell’edificio è l’aspetto esteriore di un condominio, comprensivo delle pareti esterne e degli eventuali elementi di pregio architettonico. Essa può essere definita come l’insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che caratterizzano l’edificio, imprimendogli una propria fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico.
Come sottolineato in giurisprudenza, le facciate di un edificio in condominio o muri perimetrali, pur non avendo funzione di muri portanti, sono assimilate ai muri maestri ai fini dell’applicazione della presunzione di comunione di cui all’art. 1117 del Codice civile, in quanto determinano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici o termici, delimitano la superficie coperta e la sagoma architettonica dell’edificio stesso. Ne deriva che sono muri maestri o facciate anche i muri collocati in posizione avanzata od arretrata rispetto alle principali linee architettoniche dell’edificio (Trib. Roma 20/10/2020, n. 14381).
Al fine di valutare il pregiudizio all’aspetto architettonico, non ha rilevanza la distinzione fra la facciata principale e le altre facciate dell’edificio, in quanto, nell’àmbito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico; la facciata rappresenta, quindi, l’immagine stessa dell’edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile (C. Cass. civ. 28/06/2017, n. 16258).
L’UTILIZZO DELLE PARTI COMUNI - Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto; a tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Dunque, il singolo partecipante può servirsi della stessa, sempre con i due limiti oggettivi e soggettivi di cui sopra, anche modificando la cosa comune, per il miglior godimento della stessa, fino a sostituirla con altra che offra maggiore funzionalità.
Pertanto, le modificazioni di un bene condominiale per iniziativa del singolo condomino (art. 1102 del Codice civile) sono lecite nelle sole ipotesi in cui esse, oltre a non comprometterne la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico, ed a non alterare la destinazione del bene, non siano lesive dei diritti degli altri condomini relativi al godimento sia delle parti comuni interessate alla modificazione, sia delle parti di loro proprietà.
Si evidenzia che la valutazione della violazione del pari uso deve essere nel concreto ravvisabile nel senso che l’uso privato toglierebbe reali possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini-utenti. Di talché, spetta a chi si oppone all’utilizzo del bene comune dimostrare il minore uso da parte degli altri o di chi vi ha interesse (Trib. Cosenza 22/08/2020).
In definitiva, il singolo partecipante può usare - con i citati limiti - la cosa comune nella sua interezza, indipendentemente dal fatto che sia titolare di una quota maggiore o minore della comproprietà ragguagliata al valore dell’appartamento di sua pertinenza.
IL DECORO DELL’EDIFICIO - Si intende l’insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell’edificio condominiale, idonee a conferire al fabbricato una propria identità. Costituisce un limite all’esecuzione di opere nel condominio, anche se su parti private.
Secondo i giudici, la nozione di decoro architettonico fa riferimento alla preservazione di determinate linee armoniche dell’edificio o di un determinato “stile” del fabbricato rispetto ad innovazioni atte ad alterarne composizione e tratti. Si tratta di una nozione elastica che viene ad assumere un significato concreto ed intellegibile solo se calata in un determinato contesto (TAR Toscana 07/11/2023, n. 1019).
Nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà originaria di linee e di stile, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero alla visibilità delle alterazioni (C. Cass. civ.12/06/2023, n. 16518).
L’assetto architettonico dello stabile costituisce un valore di interesse sovraindividuale, al cui rispetto ciascun condomino deve ritenersi tenuto, nell’esercizio delle proprie facoltà dominicali inerenti sia all’unità immobiliare in proprietà esclusiva che alle forme di godimento delle parti comuni (Trib. Roma 10/02/2021, n. 2305).
Ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell’edificio condominiale, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, in quanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietano l’alterazione (C. Cass. civ. 13/11/2020, n. 25790).
L’INSTALLAZIONE DEL CONDIZIONATORE SULLE PARTI COMUNI - Salvo restrizioni del regolamento di condominio ed eventuali limitazioni da parte del Comune di appartenenza (aspetti di pregio, ecc.), occorre individuare gli aspetti che consentono una installazione legittima.
Secondo una posizione giurisprudenziale, salvo determinati limiti, il singolo condomino può liberamente usare la cosa comune, anche in modo particolarmente intenso. Quindi è legittima l’installazione da parte del singolo condomino di un impianto di condizionamento su un prospetto interno del fabbricato (Trib. Napoli 21/10/2003, n. 10541).
A tal fine, non è necessaria l’autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale che, ove intervenisse, potrà essere considerata come apprezzamento in concreto del fatto che l’uso più intenso non impedisce il pari uso della cosa comune agli altri condomini.
Quindi sussiste il diritto all’installazione di un gruppo moto-condensante per l’impianto di condizionamento dell’aria a servizio del locale commerciale condotto in locazione e facente parte dell’edificio condominiale (Trib. Roma 01/06/2006, n. 18767).
Resta inteso che l’installazione non deve impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (C. Cass. civ. 13/07/2017, n. 17400: la Suprema Corte, ha rigettato il ricorso, in quanto l’impianto di condizionamento dell’aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l’installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano).
LA RIMOZIONE DEL CONDIZIONATORE - Nonostante il riconoscimento del diritto di ciascun condomino (art. 1102 del Codice civile), tuttavia, ci sono alcune condizioni in cui l’installazione del condizionatore può risultare vietata.
In alcuni casi, in giurisprudenza, i giudici hanno sottolineato che il posizionamento sulla facciata di un condominio in corrispondenza di una finestra di un’unità esterna di un condizionatore posto su due zanche costituisce innovazione vietata in quanto vìola il decoro architettonico della facciata stessa. Tale unità esterna interrompe le linee architettoniche dell’edificio. La voluminosità del corpo sporgente e la sua attitudine a variare l’aspetto esterno dell’edificio, oltre che a costituire un pericolo rappresentato dall’eventualità che un suo distacco, con caduta sul sottostante marciapiede e conseguenti responsabilità non soltanto del singolo condomino, ma anche del condominio e del suo amministratore, rappresentano una violazione delle previsioni codicistiche in materia (artt. 1120 e 1102 del Codice civile) (App. Milano 24/04/2014, n. 1558).
Secondo altra posizione, l’infissione sul muro comune da parte di un condomino di un ingombrante oggetto (nella fattispecie installazione di un grosso motore di condizionatore su una pregevole facciata prospiciente la pubblica via) di proprietà esclusiva ed a proprio servizio esclusivo che modifica in modo stabile - peggiorandone l’aspetto estetico - la facciata, costituisce, quali che siano stati i motivi “interni” alla sfera del condomino (personali e tecnici) che lo abbiano indotto ad effettuare l’installazione, un quid pluris rispetto ad una mera questione di limiti reciproci all’uso comune della facciata medesima (Trib. Milano 27/06/2009).
Inoltre, mentre l’apertura di un piccolo foro (nella specie del diametro di due centimetri) costituisce modifica senz’altro consentita, al contrario l’immissione del tubo portante la condensa proveniente dal condizionatore nello scarico pluviale dell’edificio ne altera, di fatto, la destinazione che è unicamente quella di raccogliere e far confluire le acque meteoriche (Trib. Padova 22/02/2011, n. 352: deve essere escluso che al condomino possa essere consentito di utilizzare il pluviale comune per lo scarico di acque di provenienza domestica).
SOLUZIONE AL QUESITO |
Dalla redazione
Il contenzioso e le riserve negli appalti di lavori, servizi e forniture: disciplina ed esempi pratici
Il pre-contenzioso nei lavori pubblici: riserve, relazione riservata e accordo bonario
Stato legittimo dell’immobile: esempi di dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni commerciali e richieste di bonus
Cambio di destinazione d’uso tra Decreto Salva Casa e norme regionali
Guida alla predisposizione del PTPCT per PPAA ed enti di piccole dimensioni

Manuale pratico per gli accordi con il fisco

Codice della strada 2025 e Regolamento
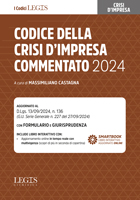
Codice della crisi d'impresa commentato 2024

Il diritto del minore alle relazioni familiari